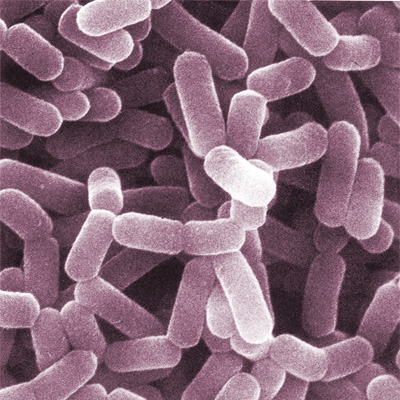Sempre più spesso si sente parlare di picchi glicemici e della necessità di controllarli per stare in una condizione di vigore e benessere.
Prima di parlare di picchi glicemici però bisognerebbe aver chiara la differenza tra indice glicemico e carico glicemico, nonché aver appreso che non sono solo i carboidrati a stimolare la produzione di insulina.
Picchi Glicemici: due definizioni per orientarci
“L’indice glicemico (IG) è un sistema di classificazione numerica utilizzato per misurare la velocità di digestione e assorbimento dei cibi contenenti carboidrati e il loro conseguente effetto sulla glicemia, cioè sui livelli di glucosio nel sangue. Un cibo con un punteggio dell’IG alto produce un grande picco momentaneo di glucosio dopo il suo consumo. Al contrario, un alimento con un basso indice glicemico provoca un lento rilascio di glucosio nel sangue dopo il suo consumo.”
“ll carico glicemico o CG (dall’inglese Glycemic load, abbreviato in GL) è un parametro che stabilisce l’impatto sulla glicemia di un pasto glucidico in base al suo indice glicemico (IG) e la quantità di carboidrati contenuti al suo interno. […] La formula per calcolarlo è: GL = (indice glicemico di un alimento x la quantità di carboidrati contenuti nell’alimento) diviso per 100. Maggiore è il carico glicemico maggiore è il conseguente innalzamento dei livelli glicemici e il rilascio di insulina nel sangue.”
E’ abbastanza evidente quindi che consumando grandi quantità di alimenti ad alto indice glicemico, per effetto del carico glicemico si avrà un picco glicemico e conseguentemente la produzione di insulina aumenterà molto rapidamente.
Ciò detto si apre un mondo di consigli per limitare questo effetto che, se reiterato nel tempo (parlo di anni e abitudini alimentari), può portare ad insulino-resistenza e diabete di tipo 2.
Dieta a basso indice glicemico
Uno dei consigli più diffusi per una dieta a bassa indice glicemico è quello di consumare insieme ai carboidrati anche quote proteiche importanti.
Il classico pasto da body-builder riso-bianco e petto di pollo non controlla affatto la produzione di insulina.
Nel caso specifico, sapendo che l’insulina è un ormone anabolizzante, l’abbinamento viene utilizzato per permettere un più facile assorbimento della quota proteica. L’insulina infatti, contrariamente alle dicerie che la vogliono coinvolta solo nel metabolismo dei glucidi, stimola anche la sintesi proteica (non è un caso che molti body-builder professionisti la utilizzino in forma esogena come doping).
Più in generale, chiusa questa piccola digressione nel mondo del body-building, va detto che questa presunta azione “magica” delle proteine nel limitare la produzione di insulina e conseguentemente nel tenere basso il carico glicemico non è del tutto vera.
…proteine e insulina?

Sono proprio le proteine, o meglio alcuni aminoacidi, a stimolare la liberazione di insulina.
Infatti anche le proteine, sebbene possano contribuire a ridurre il carico glicemico dei carboidrati, stimolano la liberazione di insulina.
Sono leucina, valina, lisina e arginina ad avere un effetto insulinogenico. Se vi preparate riso e tonno (magari al naturale) rischiate quindi di vedere aumentare la vostra glicemia più di quanto questa non farebbe se mangiaste solo tonno o solo riso. Carico glicemico e indice glicemico infatti non considerano l’effetto insulinogenico delle proteine. Se proprio, proprio volete seguire questa via le sperimentazioni fatte su me stesso mi hanno “suggerito” di limitare la quantità percentuale degli alimenti glucidici a favore di quelli proteici, rimanendo complessivamente su quantità totali modeste.
Meglio con i grassi!
Ora, siccome non son tipo da “patire la fame” preferisco di gran lunga aggiungere ai miei pasti una discreta quota di grassi che, questi sì, rallentano l’assorbimento degli zuccheri contenuti nei carboidrati non hanno alcun effetto sulla produzione di insulina. Attenzione non sto dicendo di far “galleggiare” il riso nell’olio (mi raccomando sempre Extra Vergine d’Oliva, spremuto e usato a freddo!) ma di fare un uso assennato di questi macronutrienti.
Eccoci quindi a parlare una volta ancora dei grassi che, demonizzati per decenni, sembrano finalmente sdoganarsi dal ruolo di “cattivi” impenitenti! Del resto, se pensate per un attimo di essere i protagonisti di uno di quei reality dedicati alla sopravvivenza estrema, scoprirete immediatamente che la natura di un bosco offre ben poche possibilità di approvvigionarsi di alimenti glucidici. Del resto sembra che anche i nostri avi cacciatori-raccoglitori, quando riuscivano a predare qualche animale, preferissero mangiarne prima le parti molli (tipicamente più ricche di grassi) piuttosto che i tessuti muscolari (ricchi invece di proteine). La scelta era dettata dall’estrema difficoltà di conservazione degli alimenti (impossibile per le parti molli e molto difficile per la parte muscolare). I nativi americani (ma anche molte altre popolazioni che hanno tramandato fino a noi abitudini ancestrali) essiccavano la carne mangiando subito alcune parti molli.
Tutto questo mi conforta una volta ancora sul fatto che l’essere umano non sia una macchina fatta per andare a zuccheri, non almeno tanti quanti le moderne industrie alimentari ci vorrebbero far credere essere necessari per vivere in salute.
Bene anche con le fibre
Concludo questo articolo dedicando un paragrafo alle fibre, anch’esse molto presenti nel mondo da cui proveniamo, che, come i grassi, rallentano l’assorbimento dei carboidrati (e più in generale anche degli altri nutrienti). Non ultimo poi l’effetto “meccanico” che queste sostanze hanno nel favorire la motilità intestinale preserverà tutti coloro che abusano con una certa frequenza di carboidrati e/o proteine da processi fermentativi o putrefattivi.
Se ti è piaciuto questo articolo approfondisci l’argomento leggendo lo speciale sulla dieta!





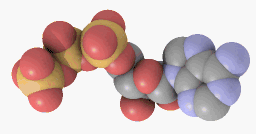


 Personalmente nella mia alimentazione faccio grande uso di verdura cruda. Può sembrare banale ma anche il metodo di cottura più delicato (il vapore ad esempio) finisce per impoverire notevolmente il valore nutrizionale di ogni ortaggio o, salvo alcune eccezioni, la biodisponibilità dei suoi micronutrienti. Non solo, alcuni alimenti con la cottura mutano in modo determinante la quantità di zuccheri e il loro indice glicemico. Questo accade per un processo che tecnicamente si chiama gelatinizzazione dell’amido che altera in modo anche molto marcato l’indice glicemico.
Personalmente nella mia alimentazione faccio grande uso di verdura cruda. Può sembrare banale ma anche il metodo di cottura più delicato (il vapore ad esempio) finisce per impoverire notevolmente il valore nutrizionale di ogni ortaggio o, salvo alcune eccezioni, la biodisponibilità dei suoi micronutrienti. Non solo, alcuni alimenti con la cottura mutano in modo determinante la quantità di zuccheri e il loro indice glicemico. Questo accade per un processo che tecnicamente si chiama gelatinizzazione dell’amido che altera in modo anche molto marcato l’indice glicemico.